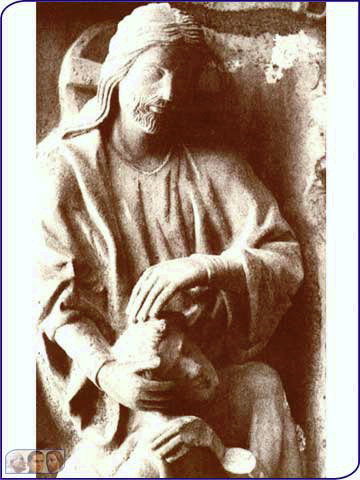Luisa Muraro,
30 novembre 2008
Impara a scegliere....
Luisa Muraro,
26 novembre 2008
Senza uguaglianza ...
18 novembre 2008
Il coraggio umile
17 novembre 2008
"Un metro di libri a tutti"
"La Stampa", 21 maggio 2008
Ricordando Luigi Malerba. Fra le sue felici follie l'invenzione nel 1972 della Cooperativa Scrittori
«Un metro di libri!», esclama con il suo vocione Cesare Zavattini, «Chiederemo alle cooperative edilizie di prevedere per ogni appartamento uno scaffale di un metro!». Zavattini è un vulcano di idee che però gli vengono solo se deambula. Va avanti e indietro per il salotto della sua casa romana, in via sant'Angela Merici, con le pareti ricoperte di quadretti in formato cartolina. I presenti parlano a voce alta per allinearsi al volume della sua e Cesare (70 anni) si raccomanda: «Parliamo piano, di là c'è mia mamma che dorme». Riprende a spiegare: «Per ogni nuova casa ci sarà nel muro una nicchia per metterci un metro di libri e a riempire quel metro ci penseremo noi». Quel «noi» indica la Cooperativa Scrittori, casa editrice nata nel '72 dalla costola romana del Gruppo '63, come reazione alla prima grande concentrazione editoriale, con la Rizzoli che acquisiva marchi in difficoltà e dai libri si allargava ai periodici, alle cartiere, alle librerie, al cinema, fino ad arrivare nel 1974 al Corriere della Sera. Rievochiamo questa lontana avventura per rendere omaggio a Luigi Malerba, che ne fu uno degli ideatori e la sostenne con entusiasmo e generosità. Letta la notizia sull'Espresso, dissi ad Angelo Gugliemi, uno dei promotori, che mi sarebbe piaciuto essere della partita e lui mi portò con sé ad una delle prime riunioni a casa Malerba, in via di Tor Millina, a due passi da piazza Navona. Luigi mi accolse come un vecchio amico e io gliene sono sempre stato grato. Alfredo Giuliani, Nanni Balestrini, Elio Pagliarani, Walter Pedullà, con un giovane Paolo Mauri, futuro capo servizio cultura a Repubblica, erano i più assidui; completava la squadra Nico Garrone, segretario. In un esercito di generali, io ero l'unico sergente, felice e sconosciuto; scrivevo e riscrivevo i comunicati stampa e andavo alla posta a spedire i lunghi telegrammi che Zavattini mi dettava al telefono. Tornando a quel metro da riempire di libri, approvata l'idea, cominciò il fantastico gioco di cosa metterci e cosa escludere. Disco verde per la Costituzione italiana e per una grammatica di base, il progetto si arenò sulla Bibbia: un editore laico e progressista deve avere nel suo catalogo, per essere completo, una Bibbia? Non era un dilemma da poco in anni in cui un marchio editoriale, oggi diremmo un brand, era anche una bandiera. Non siamo stati gli unici ad avere questo problema. Anni dopo, raccogliendo testimonianze per un documentario televisivo, mi sono imbattuto nel fantasma di una Bibbia mai nata anche in casa Einaudi. Me ne parlarono Carlo Muscetta e Franco Lucentini che si era messo a studiare l'ebraico (una delle diciassette lingue che era arrivato a conoscere) per controllare il lavoro di un tale che aveva incantato l'editore con la promessa di una nuova rivoluzionaria versione, rivelatasi una sola. Altro tema rovente: per rappresentare la narrativa italiana del Novecento serviva un racconto lungo o un romanzo breve. In una pausa della discussione azzardai il nome di Carlo Cassola: per me Il taglio del bosco è un capolavoro. Zavattini oppose un rifiuto netto, senza appello: «Cassola no! Non se ne parla!». Piemontese trapiantato a Roma, non avevo perso il vizio della puntualità; la volta successiva, arrivato prima degli altri a casa di Cesare, gli chiesi il favore di spiegarmi le ragioni del suo veto. Mi disse che anni prima, non potendo essere presente a un convegno di scrittori e cineasti, aveva inviato un telegramma. Cassola, presidente di turno, aveva aperto la sessione dicendo: «Abbiamo qui un telegramma di Zavattini, ma siccome è molto lungo lo diamo per letto e lo alleghiamo agli atti». Cassola proscritto per reato di leso telegramma! Nell'arco di quattro o cinque anni la Cooperativa Scrittori ha pubblicato tra gli altri libri di Alberto Arbasino, Furio Colombo (Iper Television), Umberto Eco (Il Superuomo di massa) Elvio Fachinelli, Francesco Leonetti. Di un bellissimo libro di poesie di Antonio Porta che doveva intitolarsi Utopia del nomade e poi uscì con il titolo Week-end, posseggo il dattiloscritto originale e sarei lieto di consegnarlo a chi custodisce le carte del poeta. La grafica, affidata al grande Giuseppe Trevisani prematuramente scomparso, era di una rigorosa e accattivante bellezza. Trevisani ideò per le copertine una gabbia di color mattone, come quella disegnata da Bruno Munari per Einaudi, rossa per i Saggi, blu per la collana scientifica, viola per gli studi etnografici, verde per la cultura storica. A due terzi la pagina è tagliata da una sbarra orizzontale; il logo è una C grande e spessa dentro la quale è annidata una S come un tuorlo dentro un uovo. La prima uscita fu un'impresa ciclopica di cui andare giustamente orgogliosi: la pubblicazione, su proposta di Valerio Riva, del testo integrale della relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia. Tre volumi, in edizione reprint, per tremila pagine, corredate da tre introduzioni e dall'indice dei nomi, venduta al prezzo di costo, 12.500 lire. Come abbiamo scritto nella prefazione: «Le tremila pagine della relazione dovrebbero essere di dominio pubblico perché pubblicate negli atti parlamentari; in effetti ne sono state stampate copie in numero così limitato da non essere nemmeno sufficienti per i soli deputati e senatori, né si trovano in alcuna biblioteca al di fuori del Parlamento». Fu un gesto insieme legalitario ed eversivo, come dovrebbe sempre essere l'editoria militante. L'opera uscì nel maggio del 1973; dovevamo presentarla in anteprima a Rimini, al congresso della Lega delle Cooperative, ma il libro non era pronto, c'era solo il menabò con le pagine bianche, così portammo quello. Toccava a me, al sergente, l'onore e l'onere di percorrere il lungo corridoio centrale dell'immensa platea tenendo in braccio quei tre volumi che del libro avevano solo la copertina e consegnarli al presidente con un'accorata raccomandazione: «Mi raccomando, non li apra». La sussurrai, ma il microfono era aperto e la mia voce si diffuse in tutta la sala. Il punto di massima visibilità fu toccato al convegno di Orvieto dal 1° al 4 aprile 1976, sul tema Il lettore e lo scrittore. La Cooperativa Scrittori fu una bella utopia. Del resto l'aria di Roma è propizia alle utopie editoriali, è sufficiente ricordare Savelli, i Millelire della Stampa Alternativa di Marcello Baraghini, la Newton Compton, la Minimum Fax, queste ultime ancora vive e vegete. Ammettiamolo una buona volta: se uno è totalmente sano di mente non fa l'editore.
15 novembre 2008
"È così la rugiada..."
E come olio prezioso sul capo,
È così la rugiada dell'Ermon
Poesia
11 novembre 2008
Insegnare
Un mio giovane amico di freschissima e brillantissima laurea in giurisprudenza mi ha chiesto un colloquio onde ricevere da me preziosi consigli. Ha ottenuto quel colloquio per puro affetto, nonostante il sottoscritto sia dell’idea che un giovane che chiede consigli a un vecchio debba essere guardato con sospetto. Un giovane deve fare la guerra ai vecchi, non tenerseli buoni; un giovane che non ha ancora capito che i vecchi sono avarissimi di consigli veramente utili, intenti come sono a conservare con le unghie e con i denti le loro posizioni, cercando di mantenersi saldi i loro privilegi il più a lungo possibile e a diretto discapito dei giovani, un giovane a tal punto sprovveduto e indifeso difficilmente saprà incontrare e riconoscere quei rarissimi uomini di grande elevazione morale o quei più ancora rari santi di singolare spiritualità che vorranno tornargli veramente utili.
Tanto vale che ritorni alla casella di partenza e cominciare da capo. Comunque sia il colloquio c’è stato e quanto sopra previamente e onestamente riportato. Ma il giovane giurisprudente non si è dato per vinto e mi ha raccontato della sua grande passione: insegnare, e poterlo fare nelle scuole medie superiori mettendo a frutto le grandi lezioni ricevute ed imparate, dando corpo all’interiore insopprimibile vocazione alla trasmissione di valori e conoscenze.
Ma bene, ma bene, ma bene, che buona notizia, che sollievo sapere che ci sono ancora giovani così motivati. Ma, si duole madido di sorgiva costernazione il giovane virtuoso, ma ho appena scoperto che in una scuola non ci posso mettere piede; né ora e, se continua così come pare, né mai. Il grande tema dell’attualità è quanti insegnanti riuscire a cacciare, non quanti assumerne. Perspicace osservazione del brillante giurisprudente, dolente coscienza della cruda realtà. E capisco che non è un consiglio che pretende, ma un poco di affranta partecipazione, quanto basta a mitigare, condividendola, la sua delusione per questo stato di cose, cinicamente predisposto all’annientamento delle giovanili attese.
Invece si da il caso che un consiglio ce l’ho da dargli; niente di eccelso ma un buon consiglio, ragionevole, di semplice attuazione, volendo. La scuola statale non ti vuole? È orrendo, ma è così. Puoi cambiare il governo, il bilancio, la riforma? No, non mi pare, non ti pare. Ma se è insegnare che vuoi, che lo vuoi fortemente, allora falla tu una scuola. Cercati un pugno di colleghi, altrettanto motivati, altrettanto preparati, indebitatevi con i parenti, vendetevi le moto e i cappotti, cercatevi un posto da affittare in centro città e fondate la vostra scuola. Sceglierete voi l’ispirazione e il metodo; siete liberi di fondare una scuola laica o cattolica, libertaria o pestalozziana, steineriana o gentiliana. Come sceglierete voi il genere di studenti a cui vorrete infondere coscienza e sapere; potete fare una scuola per educare al meglio i figli dei ricchi oppure per elevare quelli dei poveri, una scuola mista o solo per stranieri o solo per italiani, per ambosessi o uno solo. Mai come in questo momento siete favoriti nella vostra impresa, e più andrà avanti questa riforma più sarete richiesti e benedetti, perché farete per i vostri potenziali utenti ciò che la scuola statale presto non sarà più in grado di fare.
Il giovane amico ne è rimasto sbigottito, di certo annientato nella probabile stima che nutriva per me. Ho riconosciuto la cocente delusione e ho intravvisto la malcelata rabbia per quella che gli è parsa una stupida provocazione. Come se avessi offeso le sue più legittime e profonde pulsioni. Lui mi aveva aperto il suo cuore e io lo ripagavo con l’irragionevole e mortificante proposta di rinunciare al primario diritto di insegnare in una scuola statale. Gli ho spiegato che l’idea non è così nuova, che Don Milani quando ha voluto insegnare lo ha fatto senza chiedere di entrare in graduatoria. E come lui molti altri insigni riformatori e pedagoghi; gli ho riferito che ho conosciuto personalmente fior fiore di latinisti, matematici, filosofi che non hanno mai messo piede in una scuola ma hanno passato la loro vita dando lezioni private perché così avevano scelto, facendo più e meglio per i loro studenti degli insegnanti incattedrati. In un momento di così profonda crisi del sistema, l’ho incalzato, se hai veramente determinazione per realizzare un’idea, e se la tua idea ha sufficiente riscontro nei bisogni veri e concreti, allora non puoi che avere successo.
Mi ha lasciato dicendomi in chiaro tono d’accusa che gli avevo dato la mazzata finale, che lui, tanto per cominciare, non conosceva una sola persona al mondo che avrebbe accettato di far parte di un’impresa del genere. Almeno questa ultima osservazione l’ho trovata concernente. Il mio giovane amico fa parte di una generazione educata alla rinuncia dell’intrapresa, destinata all’incertezza non semplicemente del posto di lavoro, ma alla sfiducia in se stessa e delle proprie possibilità di iniziativa. Se è largamente favorita l’iniziativa nella sua accezione più volgare di “fare soldi”, non è nemmeno presa in considerazione l’accezione più nobile, produttiva e necessaria di creare, mettere in gioco la propria vita - tutto quello che si ha, fossero anche solo le catene - per la realizzazione di un’idea, di un progetto, di un sogno che non sia compendiato nell’ignobile riffa di uno dei molti gratta e vinci a disposizione delle illusioni giovanili. “Sfangarla” è tutto quello che credono di poter fare; sfangarla a “Saranno Famosi” o con un posto da qualche parte a fare qualcosa. E i migliori tra loro, quelli dai sogni ancora non pervertiti in miseria dello spirito, sognano e basta. Non c’è e non ci sarà riforma della scuola così esiziale come lo è la mancata riforma della società che se la mantiene a malavoglia.
1996 - L'esibizione del privato - 2008
Questo mondo senza più vergogna
“La Repubblica”, 19 agosto 1996
LE SCRIVO, gentile Raffaella Zardo, perché sono stato colpito da una frase che lei ha pronunciato all' uscita del palazzo di Giustizia di Biella. Intervistata dai giornalisti lei ha detto: "Non ho nulla da nascondere, nulla di cui vergognarmi". Penso che lei si riferisse alle accuse di aver frequentato e fatto frequentare magari con un eccesso di disinvoltura e per ragioni di carriera personaggi pseudoculturali che vendono in confezione filosofica alcune idee elementari che per caso attraversano la loro mente e poi sprecano pagine di giornali per precisare che lei non era nella loro casa ma in quella della figlia o degli amici della figlia. Di questo, gentile Raffaella, non deve vergognarsi. Coltivare sentimenti di gerontofilia può talvolta tornare utile nella cura degli anziani. E neppure deve vergognarsi di aver frequentato, non si sa se per ragioni di sentimento o di autoaffermazione (la differenza in certe persone è molto difficile da tracciare) camere da letto di personaggi dalle facce che sembrano fatte in serie e programmate per adescare con il potere quel che a loro non riesce con la seduzione. Anche di questo non si deve vergognare. In fondo è un fenomeno molto diffuso in tutti i posti di lavoro, dai più umili ai più elevati come ad esempio il raggiungimento di una cattedra universitaria. Perché proprio lei deve "nascondere" quello che è sotto gli occhi di tutti? Perché deve "vergognarsi" di una pratica così frequente? QUEL CHE invece mi disturba è che lei con quelle frasi: "Non ho nulla da nascondere, non ho nulla di cui vergognarmi" dà manforte a quella pubblicizzazione del privato che è l'arma più efficace impiegata nelle società conformiste per togliere agli individui il loro tratto "discreto", "singolare", "privato", "intimo", dove è riscontrabile quella riserva di sensazioni, sentimenti, significati "propri" che resistono all' omologazione che nelle nostre società di massa è ciò a cui il potere tende per una più comoda gestione degli individui. Allo scopo vengono solitamente impiegati i mezzi di comunicazione che, dalla televisione ai giornali, con sempre più insistenza irrompono con "indiscrezione" nella parte "discreta" dell' individuo per ottenere non solo attraverso test, questionari, campionature, statistiche, sondaggi d' opinione, indagini di mercato, ma anche e soprattutto con intime confessioni, emozioni in diretta, storie d' amore, trivellazioni di vite private, che sia lo stesso individuo a consegnare la sua interiorità, la sua parte discreta, rendendo pubblici i suoi sentimenti, le sue emozioni, le sue sensazioni, secondo quei tracciati di "spudoratezza" che vengono acclamati come espressioni di "sincerità", perché in fondo: "Non si ha più nulla da nascondere, nulla di cui vergognarsi". A parte che "vergognarsi" è un verbo riflessivo che dunque rinvia a una riflessione, a una relazione con se stessi di cui non è proprio il caso di vergognarsi, c' è da notare anche che è un verbo che dice la nostra esposizione agli altri. "Vergogna" infatti viene da vereor gognam che significa "temo la gogna, la mia esposizione pubblica". E questa è la ragione per cui solitamente non ci si vergogna della colpa, ma della nostra esposizione agli altri che il nostro pudore avverte più disdicevole della colpa. Quando lei dice "non ho nulla di cui vergognarmi" non sta dicendo solo "non mi vergogno, quindi non sono colpevole", ma anche: "Non mi vergogno, quindi non temo l' esposizione agli altri. Ho oltrepassato quello che per chiunque sarebbe il pudore e ho fatto della spudoratezza non solo la mia virtù, ma la prova della mia sincerità e della mia innocenza". In questo modo lei dà un ottimo esempio di quell' omologazione dell' intimo a cui tendono tutte le società conformiste con somma gioia di chi le deve gestire perché, una volta pubblicizzata, l' intimità viene dissolta come intimità, e gli altri, che dovrebbero stare al confine esterno dell' intimo, diventano letteralmente "inevitabili" ogni volta che lei, ma, stante il suo esempio, ciascuno di noi, prova una sensazione, un' emozione, un sentimento. Questi tracciati profondi dell' anima, in cui ciascuno dovrebbe riconoscere le radici profonde di se stesso, una volta immessi "senza pudore" nel circuito della pubblicizzazione, quando non addirittura in quello della pubblicità, non sono più propriamente "miei", ma "proprietà comune", e questo sia in ordine alla qualità del vissuto, sia in ordine al modo di viverlo. Le espressioni da lei usate: "Non ho nulla da nascondere, nulla di cui vergognarmi" significano innanzitutto: "Sono completamente esposta", "non custodisco nulla di intimo", "la mia anima è completamente depsicologizzata". Se lei dovesse diventare il modello di tante ragazzine che sognano scintillanti carriere, questa sarebbe la sua vera colpa, perché il pudore, prima di una faccenda di mutande che uno può cavarsi o infilarsi quando vuole, è un faccenda d' anima che, una volta depsicologizzata perché si son fatte cadere le pareti che difendono il dentro dal fuori, l' interiorità dall' esteriorità, non esiste semplicemente più. Lei potrebbe obiettarmi che siccome il male avviene di solito segretamente, "segretezza" e "privato" sono per l' opinione pubblica prove del male. E allora, per smentire l' opinione pubblica, omologata su questo pregiudizio, non resta che la spudoratezza di chi si tiene sempre pronto, "mani alla chiusura lampo", per interviste, pubbliche confessioni, rivelazioni dell' intimità. E con ciò siamo approdati al nostro ultimo punto, forse quello decisivo. Con il suo invito a "non aver nulla da nascondere, nulla di cui vergognarsi", che nelle società conformiste è sempre accolto come prova della virtù, lei, anche se non lo sa, sta incitando tutti, come del resto fanno numerose trasmissioni televisive particolarmente seguite, a collaborare attivamente e con gioia alla propria deprivatizzazione. Quanti sono interessati a che l' individuo non abbia più segreti e al limite neppure più un' interiorità, perché le pareti della casa di Psiche sono crollate, non potranno che esserle riconoscenti per avere anche lei dato il suo contributo a trasformare la spudoratezza in una virtù: la virtù della sincerità. Per quanto la cosa possa apparire strana la sua realizzazione nella nostra società è già in corso e il processo di eliminazione del pudore è quasi completo perché il pudore può essere non solo sintomo di "insincerità", ma addirittura, e qui anche gli psicologi danno una mano, di "introversione", di "chiusura in se stessi", quindi di "inibizione" se non di "repressione". E inibizione e repressione, recitano i manuali di psicologia, sono sintomi di un "adattamento sociale frustrato", quindi di una socializzazione fallita. Vede gentile Raffaella Zardo dove si può arrivare avviando una sequenza un po' disinvolta di sillogismi? Ma purtroppo la sequenza è avviata e la nostra vita è diventata proprietà comune. E allora perché non lasciarsi intervistare senza riserva e senza pudore? Ma anche il nostro corpo è diventato proprietà comune, e quel che un tempo era prerogativa di alcune dive, farsi misurare seni e sederi e pubblicar le relative cifre sotto la fotografia, oggi è il gioco di qualsiasi ragazza che non vuol passar per inibita. Ma anche il sesso è diventato proprietà comune e, dalla stampa alla televisione, è un susseguirsi di articoli e servizi sui piaceri e sulle difficoltà della camera da letto, redatti sotto forma di consigli, in modo confidenziale, come se fossero rivolti solo a te e non a cinquanta milioni di orecchie. Questo significa "non aver nulla da nascondere, nulla di cui vergognarsi". Significa che le istanze del conformismo e dell' omologazione, a cui lei gentile Raffaella Zardo ha dato una mano, lavorano per portare alla luce ogni segreto, per render visibile ciascuno a ciascuno, per toglier di mezzo ogni interiorità come un impedimento, ogni riservatezza come un tradimento, per non permettere ad alcuno di vivere e lavorare in case o uffici che non siano di vetro, per apprezzare ogni volontaria esibizione di sé come fatto di lealtà se non addirittura di salute psichica. E tutto ciò, anche se lei e come lei molti altri non ci pensano, approda a un solo effetto: attuare l' omologazione della società fin nell' intimità dei singoli individui e portare a compimento il conformismo. In fondo non è un' operazione difficile. Basta "non aver nulla da nascondere, nulla di cui vergognarsi".
___
07 novembre 2008
Le città invisibili
L'estate è la stagione in cui si è più disposti a leggere o a rileggere i grandi libri. La Stampa ha chiesto alle sue firme di raccontare ai lettori i capolavori della letteratura mondiale. Le città invisibili, il capolavoro di Italo Calvino, sono un rebus: un'immagine figurata composta di parole di ardua decifrazione. Opera imprendibile, misteriosa, dalla struttura complessa e articolata, viene pubblicata dal suo autore quando sta per varcare la soglia dei cinquant'anni. Nel 1972 Calvino vive a Parigi con moglie e figlia; s'è allontanato dall'Italia, e sembra passare di colpo da una giovinezza a lungo protratta ad una vecchiaia incipiente, saltando a piè pari l'ardua maturità, scoglio su cui si è infranto il suo primo maestro, Cesare Pavese. Pasolini, sciamano e poeta, l'ha capito: questa è l'opera di un giovane, paziente artigiano dall'umore cristallino, e insieme di un vecchio, uno «che ha visto passare la vita». Questa duplicità è la chiave più appropriata per leggere il libro: romanzo, piccolo poema in prosa, serie di racconti a tema, riflessioni filosofiche, storie fantastiche, e altro ancora. L'autore si scinde in due: Marco Polo, il narratore delle città, e Kublai Kan, il suo ascoltatore, il giovane e il vecchio. Si tratta di 55 brevi descrizioni di città, suddivise in 9 capitoli, cui s'aggiungono i dialoghi tra Marco Polo e Kublai, in corsivo, micro-cornici che servono a dare alle singole descrizioni un senso d'insieme: aprono e chiudono il libro e ne scandiscono le parti: le città e la memoria, e il desiderio, e i segni, e gli scambi, e gli occhi, e il nome, e i morti, e il cielo, ecc. Sono città da leggere, non da guardare, poiché la loro descrizione non si lascia mai scorgere per intero (Gianni Celati). Il titolo è parte stessa del fascino del libro, proviene da uno dei capitoli finali del libro di Lewis Mumford, La città nella storia, uscito in America nel 1961 e tradotto in italiano da Comunità. Certo, dietro tutto c'è Marco Polo e il suo Milione, il trattamento per un film proposto da Mario Monicelli; e anche le sculture sottili di Fausto Melotti, mostrate allo scrittore da Paolo Fossati; e poi le idee travasate da Celati, Carlo Ginzburg, Guido Neri e Enzo Melandri in una rivista mai nata, Alì Babà, pensata insieme a Calvino in quegli stessi anni; e ancora la lettura dell'utopia pulviscolare di Fourier e un altro libro: Françoise Choay, La città. Utopie e realtà; e poi molta altra roba ancora, conosciuta e sconosciuta. Ma soprattutto dietro al capolavoro di Calvino c'è il Sessantotto visto per le strade di Parigi, la fantasia al potere, l'utopia degli studenti del Maggio, quando i boulevard si sono riempiti di ragazzi e gli studi degli psicoanalisti svuotati, come Calvino stesso racconta a Celati, suo mentore della nuova stagione. All'inizio degli anni Settanta la letteratura sembra aver perso importanza come descrizione del mondo e sua spiegazione, come iniziazione alla vita stessa e insieme suo compendio e viatico. È stata sostituita, o almeno affiancata, dal cinema, dalle arti visive, dall'estetica, e poi dalla politica stessa ora al primo posto. Le città invisibili sono la risposta che il senex-puer Calvino fornisce al cambiamento in atto, il suo personale contributo poetico. Come afferma lo scrittore in una conferenza americana dello stesso periodo, la letteratura deve cercare di dare un nome a ciò che ancora non lo ha, deve scoprire nuovi modelli d'immaginazione e svolgere un lavoro mentale necessario ad ogni progetto d'azione politica, ma anche comunicare attraverso l'autore qualcosa che è collettivo. Detto altrimenti: questo meraviglioso poema in prosa è prima di tutto un libro politico. Sulla copertina della prima edizione c'è una pietra, un gigantesco masso granitico che galleggia nel cielo sopra il mare; in cima, un castello della medesima pietra verde-azzurra del masso volante. Si tratta di un quadro di Magritte, Il castello dei Pirenei, scelto da Calvino stesso per illustrare il libro, ovvero per fornire ai propri lettori la prima e unica immagine visibile delle città contenute nel volume. Tutto il resto è, come dice il titolo, assolutamente invisibile: non si può vedere, lo si può solo raccontare. La parola chiave del libro è leggerezza, diventata solo tredici anni dopo, con le Lezioni americane, l'emblema araldico dello scrittore, sua croce e delizia postuma. Lalange, la città sognata da Kublai Kan, ha il privilegio di crescere in leggerezza. È la leggerezza dello scrivere, la leggerezza del vivere, la leggerezza dell'immaginare: la leggerezza come tema politico e persino autobiografico. Uscire da un'età segnata dalla pesantezza degli «anni di ferro» del comunismo staliniano, cui Calvino ha aderito, e dal fallimento dei «socialismi reali», per pensare qualcosa di diverso da quel mondo coeso e compatto. E allo stesso tempo tentare di superare la propria pesantezza del vivere, proiettarsi in un universo di possibilità, spazio virtuale che la letteratura sa comporre con abilità e libertà di fronte al labirinto implacabile del vivere. Il tema della morte, del disfacimento, sono ben presenti in ciascuna delle città raccontate da Marco a Kublai. Il libro, costruito su uno schema geometrico ben strutturato e cadenzato, è il tentativo di opporre al disordine del mondo non un altro ordine, bensì un disordine possibile. Del resto, Le città invisibili sono esse stesse un labirinto: il lettore non sa mai bene dove si trova. Per Calvino queste città sono un catalogo di luoghi e vite virtuali, desiderate, temute, rifiutate, irraggiungibili, «che ruotano intorno all'unico spazio vuoto dell'unica vita che ci tocca per davvero di vivere e da cui ci sentiamo - ha scritto Domenico Scarpa - separati e lontani», «che non conosciamo e che spiamo dall'alto di una palafitta come fanno gli abitanti di Bauci». Ogni città è Calvino stesso, l'uomo e lo scrittore, un suo breve ritratto: come è stato nel passato o come immagina di essere stato, o come aspira ad essere in un futuro non troppo remoto. Alla fine, chiudendo il libro, di tutto questo enigmatico poemetto restano in mente solo poche parole, una frase, un rigo, qualcosa da rammentare, qualcosa di diverso per ciascuno, e per ciascuno unico.
06 novembre 2008
La menzogna politica
Hannah Arendt
02 novembre 2008
Poesia
Anche se sappiamo che alla fine
I barbari passeranno